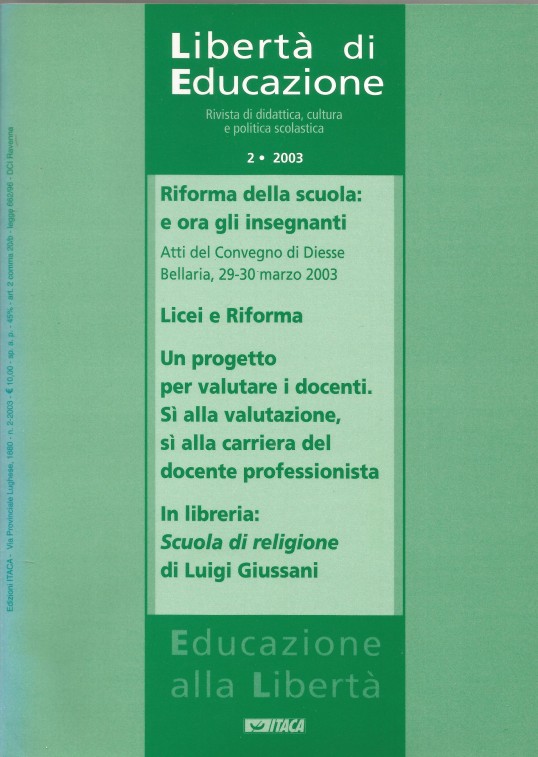
I Fratelli Karamazov
Francesco Bertoldi
Pubblicato su Libertà di educazione n.2/2003, pp. 138-42
Tutta la legge dell'esistenza umana sta soltanto in questo, che l'uomo possa sempre inchinarsi davanti all'infinitamente grande.
Le riflessioni che seguono non hanno alcuna pretesa di critica letteraria, sono solo un contributo sul versante di contenuti riferibili ad aspetti filosofico-teologici. Ci si permetta però di cominciare dicendo che anche secondo noi, come in molti hanno detto, i Fratelli Karamazov è «uno dei più grandi romanzi della storia», probabilmente il vertice, il canto del cigno di quel grande romanziere e artista che fu Dostoevskij.
1) la «potenza del bene» [1]
Rispetto ad altre opere di Dostoevskij, come Delitto e castigo, i Demoni o Umiliati e offesi, qui affiora potentemente non solo la denuncia del negativo, dei danni immensi prodotti sull'umano dalla negazione di Dio, ma la proposta di un positivo: il positivo c'è, ed è storicamente incontrabile come benefico per l'umano. Il positivo, una sorte di immagine di Cristo, appariva già in un altro grande romanzo di Dostoevskij, L'Idiota. Ma là l'eroe positivo, o che è lo stesso, l'uomo vero, era venato di tratti che si faticherebbe a non definire negativi: il principe Miškin rivelava non di rado una ingenuità che sfiorava la dabbenaggine. Lo si poteva, ad esempio, facilmente ingannare: non perché egli non capisse, perché anzi il suo giudizio era quanto mai penetrante ed acuto, ma perché dimostrava una sorprendente inettitudine all'azione, una sorta di apparente blocco della sua operatività, che ne inibiva le pur irraggiungibilmente acute intuizioni. Nei Fratelli Karamazov invece i "buoni" (in particolare lo starec Zosima e Alësa) non solo hanno un giudizio umanamente più vero e penetrante, ma sanno anche agire utilmente perché il bene trionfi nel concreto. Lo starec Zosima ad esempio opera efficacemente su coloro che lo seguono, i frutti della sua imitazione di Cristo sono in qualche modo visibili storicamente, fino al miracolo della preveggenza e della guarigione (non privo quest'ultimo però di un certo margine di interpretabilità, nel caso di Liza). Anche Alësa opera, e opera non solo, come in qualche modo già il principe Miškin, suo malgrado, ma in base ad un consapevole ed opportuno uso della sua parola e della sua azione: alla sua persona si deve ad esempio buona parte del cambiamento di Grušen'ka (cfr. l. 7°, II), come pure il cambiamento dell'atteggiamento dei ragazzini, e in particolare di Kolia Krasotkin, che da cinici diventano capaci di solidarietà e di bontà; ma, benché l'Autore non lo dica esplicitamente, la sua positiva influenza si estende anche ai due fratelli, Ivan e Dimitrij (Mitja), i quali entrambi, nell'ultima parte del racconto, conoscono una forma di sia pur parziale e ambigua conversione; chi poi può escludere che lo stesso padre dei Karamazov, Fëdor Pavlovic, sia in qualche modo toccato dalla bontà dell'ultimogenito, lui che non denuncia l'aggressione di Dimitrij, e lui che, pur divorato dal fuoco di una implacabile passione, trova il modo di ironizzare sui propri stessi sentimenti, aggiungendo, sul pacco destinato alla sua amata Grušen'ka, un «alla mia pollastrella», che ha forse, oltre ad un ovvio carattere di grottesca oggettivazione, anche un ché di autoironicamente ingenuo e di disperatamente infantile. Il realismo benefico di Alësa addirittura giunge al punto di non escludere la fuga del fratello, ingiustamente condannato per un assassinio da lui non commesso.
Ci si potrebbe ulteriormente chiedere: come opera il Bene, nel racconto di Dostoevskij? Il Bene opera mediante dei testimoni: lo starec Zosima, Alësa, l'igumeno, padre Paisij, testimoni che lo rendono storicamente incontrabile a chiunque abbia gli occhi aperti e il cuore semplice, cioè vero. E questi testimoni diffondono, irraggiano intorno a loro il Bene sia mediante la parola, sia mediante l'esempio, il comportamento. È vero che in qualche circostanza sembra che Dostoevskij dipinga un cambiamento troppo affrettato: bastano poche parole, o pochi gesti e già si attua una trasformazione di personaggi precedentemente negativi (ad esempio la conversione di Zosima, prima del duello, conversione che poggia sul ricordo del fratello morto prematuramente, il quale a sua volta appare convertirsi in un modo francamente inopinato e comunque tutto interiore). Ma per lo più il cambiamento ha come strumento una realtà visibile già in atto, dei testimoni, appunto, che con parole e soprattutto scelte concrete riescono poco a poco, progressivamente, a scuotere e a sommuovere l'animo di chi è minimamente aperto.
Sono in tal modo molti i personaggi che nei Fratelli Karamazov cambiano, aderendo al Bene o almeno avvicinadovisi: dai ragazzini che Alësa sorprende a tirare sassi a Iliuška, allo stesso Iliuška, da Grušen'ka (che, è vero, resta in un certo senso «cattiva», secondo le sue stesse parole, ma appare più ancora decisa a cambiare vita, diventando più seria e scegliendo, con la fedeltà a Mitja, di ancorarsi con fedele serietà a quel reale, con cui aveva in precedenza giocato) a Mitja, anche lui ancora pieno di passioni e di peccato, ma tutto preso da un senso di pentimento e di riscatto (a partire dal sogno del «bimbino», l. 9°, VIII) e a Ivan, che, pur orgogliosamente legato alle sue idee razionalistiche e preda, per uno strano contrappasso, di visioni mistico-sataniche, ha il coraggio di riconoscere pubblicamente la verità del suo operato, e pur sballottato dai flutti di una soverchiante tempesta psicopatologica, sembra più ancora innalzare sul più alto pennone del suo martoriato naviglio la bandiera di una ritrovata fedeltà al vero.
2) personaggi
i cattivi: uno sguardo ironico, non privo di compassione
In altre opere di Dostoevskij i "cattivi" incutevano essenzialmente paura, o erano almeno dei personaggi da prendere decisamente «sul serio»: come nel caso di Rogozin ne L'Idiota, o del principe Valkovskij in Umiliati e offesi, o di Stavroghin, Kirillov e Piotr Stapanovic ne I demoni. In loro non c´era niente di ridicolo, niente di cui si potesse ridere. In loro Dostoevskij ci raffigurava ancora un male “potente”. Ora invece nei cattivi, in quasi tutti i cattivi che i vengono presentati ne I Fratelli Karamazov c´è un che di ridicolo.
Ridicolo e buffo è il cattivo forse «centrale» del romanzo, quel Fëdor Pavlovic Karamazov, dai cui vizi partono tutti i guai che il romanzo narra. Si pensi solo il suo sproloquio con lo starec, di una sfrenata, volontario-involontaria, (tragi-)comicità. Ma ridicolo finisce pure con l'essere, nonostante tutto il suo orgoglio, lo stesso ambizioso Rakitin, figura tanto più negativa in quanto la sua cattiveria non è debolezza passionale (come nei Karamazov), ma freddo calcolo: ebbene anche lui, intellettuale da strapazzo succube delle mode razionaliste occidentali, si copre di ridicolo circuendo la ben più attempata signora Chochlakova, al cui denaro egli mira, e in onore della quale compone dei versi a dir poco grotteschi: «oh quel piccolo piedino - è un po' gonfio, poverino!»
Non parliamo poi di Maksimov, la cui negatività del resto è ben poca cosa rispetto agli altri «cattivi»: egli è un vecchietto goffamente preoccupato della sua sopravvivenza materiale e generoso di spropositi, per lo più inoffensivi. Sostanzialmente ridicoli sono «i polacchi» (l. 8°, VI e VII): dietro la loro sussiegosa altezzosità si scopre ben presto un meschino appetito di denaro, e una buffa goffaggine. Lo stesso diavolo, che appare nelle allucinazioni (ma saranno poi un puro fenomeno di psicopatologia?) di Ivan, figura come un «povero» diavolo, con poche frecce al suo arco, dimesso e grigio, privo di vera fantasia creativa.
È facile vedere come questo aspetto sia corrispondente alla già ricordata potenza del bene: se è potente il bene, quanto più è potente il bene, tanto meno lo è il male. Il male appare come facilmente smascherabile, come debole, dunque come facilmente ridicolo. Notiamo subito che «facilmente smascherabile» il male lo è solo ontologicamente, e dunque per il singolo soggetto, per l'io che abbia occhi aperti e cuore semplice: vedremo invece che, per il «mondo» invece vale una torbida soggezione alla menzogna, come emerge dal processo di Mitja. Notiamo che la debolezza del male avvicina la visione di Dostoevskij a Dante (i diavoli sono stupidi, e talora comici, mentre sono gli angeli a incutere timore e rispetto: come nella narrazione dell'ingresso alla città di Dite, «ahi quanto mi parea pien di disdegno!»), differenziandolo da gran parte della cultura moderna che ha sempre più dipinto il diavolo come un essere bello, potente e temibile, riducendo invece gli angeli a deboli ed ingenui putti.
C'e però un'eccezione, anche ne I Fratelli Karamazov. C'è un cattivo che non fa ridere affatto: è Smerdiakov. Ed è un personaggio sinceramente difficile da capire. Disgraziato fin dalla nascita, egli è testardamente chiuso alla positività della vita, tetragono fino all'ultimo in un ateismo assoluto, tanto da risultare incomprensibile. Perché, facendo ancora un paragone, di Stavroghin ne I demoni ci viene in qualche modo illustrata la logica, e anche di Kirillov. Qui invece l'autore nulla ci dice sul movente profondo dell'agire di Smerdiakov. Segno forse che, dove il male diventa assoluto e totale, ci si inabissa nella più tenebrosa assenza di logica. Il male, in sé stesso, non ha logica, è il puro assurdo, il bene essendo invece sinonimo di verità, di ragionevolezza, di bellezza.
i buoni
Il buono è senza dubbio Alësa: non nel senso che sia il più buono, questo titolo, ammesso che sia intrinsecamente legittimo, dovrebbe piuttosto spettare allo starec Zosima. Alësa però è al centro del romanzo come il suo eroe: è lo stesso Dostoevskij a dircelo, nella Prefazione.
1. Alësa genera perché è generato. È dalla sequela del suo padre spirituale, lo starec Zosima, sequela che è preparata dalla espiatrice sofferenza della madre, che egli impara a vivere la fede come l'assoluto della vita. In ogni caso è evidente che Alësa non è buono per merito suo, ma perché accoglie un dono, ed è guidato da Altro da sé, che si manifesta a lui nella concretezza del reale (lo starec, il monastero, le circostanze concrete). Commovente (anche se discutibile, quanto al merito) è l'obbedienza di Alësa: obbedire allo starec, cioè a un carisma (storicamente visibile) è condizione imprescindibile per obbedire al Mistero. E anche le circostanze non vengono da lui glissate: non vi è impegno che Alësa eviti, per quanto apparentemente banale, e in qualche caso (come la richiesta di Liza di farsi latore di una lettera per Ivan) poco meno che grottesco. Alësa è generato non dal suo genitore fisico; ben poco egli prende da lui: veramente padre è non chi mette al mondo (anche i cavalli sono capaci di figliare), ma chi gli ha insegnato il significato del vivere, come ricorda sempre don Giussani.
2. La figura di Alësa potrebbe apparire come inverosimile nella sua granitica, inscalfibile, semplicità di adesione al Vero e al Bene: una figura fin troppo perfetta. Ma neppure lui è privo di limiti: il «lezzo della putrefazione» emanato dal cadavere dello starec, se non mette in crisi la sua fede e la sua stima per il defunto, lo turba però non poco. Più ancora è degno di nota che lui pure si lascia sfiorare, sia pur per poco e senza che la cosa esca dall'ambito di una pura ipotesi fantastica, dalla tentazione della lussuria, allorché acconsente a seguire Rakitin da Grušen'ka. Lui stesso lo ammette: «Io ero venuto qui per perdermi. Mi dicevo: «e sia dunque!»» (p. 476, ed. BUR).
3. È poi importante notare che anche Alësa, come quasi tutti conosce un cambiamento, una storia: dentro una decisione sostanzialmente ininterrotta, egli viene rafforzato nella sua fede e reso capace di un amore più concreto proprio da quell'evento che sembrava dovesse metterlo gravemente in crisi, lo «scandalo» del "suo" santo starec, che a dispetto di ogni previsione, emanava un cattivo odore, apparente smentita divina della sua creduta santità.
Anche lo starec Zosima ha una storia, c'è stato in lui un cambiamento. Con qualche somiglianza col manzoniano padre Cristoforo è un duello l'occasione della sua conversione, solo che nel caso di Zosima non scorre sangue: egli si accorge prima del grave peccato che starebbe per commettere e se ne ritrae.
L'insegnamento di Zosima è illuminato dal confronto con l'altro personaggio mistico del monastero, padre Ferapont (l.4, I). È evidente che il giudizio dell'Autore è tutto a favore di Zosima: la sua visione della vita è gioiosa e caritatevole; egli è serio ma anche capace di compassione e di condiscendenza. Al contrario padre Ferapont è arcigno e coriaceo, nulla concede all'umano, che a suo parere deve interamente scomparire davanti al divino. Da notare che padre Ferapont attinga poco alla liturgia («alla Messa compariva di rado», p. 224, ed.cit.). Zosima invece accettava «i pasticcini» che le signore gli portavano, non disdegnava «il thè», come gli rimprovera Ferapont dopo la sua morte, non parla con rudezza e scortesia come padre Ferapont, ma con cordiale carità, rivelandosi capace di una speciale tenerezza paterna verso Alësa.
L'ideale cristiano che Dostoevskij ci presenta così è quello di una pienezza di umanità: non occorre rinnegare niente di davvero umano. Il santo al contrario è un vero uomo, anzi l'uomo vero.
umanità cambiate
Lo abbiamo già notato: Mitja, Grušen'ka, lo stesso Ivan, i ragazzini e Kolia non restano gli stessi. Gli eventi che accadono, e soprattutto il sacrificio che viene loro chiesto, il dolore, e la testimonianza di Alësa operano in loro un cambiamento. Un cambiamento, potremmo anche dire una conversione, che è certo di diverso tipo: totale e convinta in chi è più puro di cuore, Kolia e gli altri ragazzini; germinale e non priva di qualche zona d'ombra per Grušen'ka e Mitja, ambigua e sofferta per Ivan. Ma «il chicco di grano» costretto a morire, citato nell'esergo dell'opera, porta realmente un frutto storicamente visibile.
C'è poi anche un cambiamento verso il peggio: quello di Liza, che nell'ultima scena in cui è raffigurata, appare addirittura preda di una incipiente possessione satanica («voglio fare il male», «perché non resti più nulla di nulla», p. 780). Nelle ultime battute però anche lei sembra buttarsi, tramite Alësa, nella braccia della misericordia di Dio («Alësa, salvatemi!», p. 784).
E c'è infine almeno un caso di umanità penosamente oscillante e incapace di qualsiasi vero cambiamento, tanto verso il Bene quanto verso il male: è la signora Chochlakova, madre di Liza, in perenne balia di un pensiero frivolo e superficiale, senza rischiare mai un giudizio sulla realtà, alla mercé della cui cangiante apparenza finisce quindi per trovarsi costantemente.
3) temi
a) ciò che accade: il mistero dell'iniquità e della redenzione
Che cosa davvero accade nel romanzo? Non siamo riusciti a vedervi, come ha scritto Dell'Asta nella sua pur dotta e interessantissima introduzione, molti colpi di scena. Si direbbe invece che il romanzo, dal punto di vista degli eventi, sia piuttosto povero, e che in fin dei conti sia apparentemente fin troppo prevedibile: un delitto doveva accadere, e un delitto accade; un personaggio doveva essere sospettato, e proprio tale personaggio viene sospettato, e poi, prevedibilissimamente, condannato. La forza del romanzo non è, ci sembra, nei colpi di scena (che del resto Dostoevskij non amava particolarmente nemmeno nei precedenti romanzi), ma nel messaggio che egli vuole magistralmente trasmettere.
Qual è la sintesi della trama narrativa? Il vizio, il male rovinano l'uomo, fino all'estrema rovina, che è l'assassinio. Ma anche da questo male l'Amore misericordioso del Mistero riesce a trarre un bene sostanziale (il cambiamento del cuore di Mitja, Grušen'ka e in parte di Ivan), anche se il «mondo», immerso nella menzogna non coglie tale sostanza vera degli eventi, fermandosi a una ingannevole apparenza (come dimostra il processo).
b) la percezione mondana di ciò che accade: il trionfo della apparenza
La lunga vicenda del processo a Mitja potrebbe sembrare una troppo lunga digressione. Ma è, ci sembra, l'occasione per un giudizio sulla giustizia umana e più in generale sul "mondo" e sulla facilità con cui esso si inganna nel giudicare le cose.
un neo: il giudizio sul cattolicesimo
Dostoevskij non era tenero col cattolicesimo. Già ne L'Idiota troviamo dei giudizi spietati contro il Papato, reo di interessarsi più di vicende temporali che della fede soprannaturale. Nei Fratelli Karamazov il cattolicesimo viene preso di mira soprattutto nell'intermezzo della «leggenda del Grande Inquisitore». Fino a che punto tale racconto, messo sulla bocca di Ivan, rispecchia il punto di vista di Dostoevskij? Non ci sentiamo di determinare con esattezza questo punto: certo è che Alësa, rispondendo al fratello, ridimensiona non poco la sua critica, che, puntualizza, dovrebbe al massimo essere circoscritta a certi settori del cattolicesimo («quelli sono i peggiori tra i cattolici, sono gli inquisitori, i gesuiti!», p. 348). Il cattolicesimo è comunque reo, come minimo, di sete di potere e della pretesa di organizzare in modo preciso ogni aspetto della vita (soffocando in tal modo la «libertà dello Spirito», che «soffia dove vuole» e non può essere ingabbiato in schemi dottrinali e pastorali troppo stretti, quali apparivano all'ortodosso Dostoevskij).
Non è però il caso di soffermarsi più di tanto su questi aspetti. Perché? Perché si tratta di aspetti legati al condizionamento storico dell'Autore, che per quanto geniale, resta per certi versi pur sempre figlio del suo tempo e della mentalità della terra in cui è nato. Quello che ci deve bastare è che la sua critica si volga tutta ad aspetti pratici del cattolicesimo romano (la sua sete di potenza terrena, la sua pretesa di irregimentare e disciplinare rigidamente), ma non intacchi l'essenziale, cioè il dogma, la comune adesione alla fede di Pietro. Il resto è solo transeunte residuo di condizionamenti storici.
[1] Allusione al film Dies irae di Dreyer (nella cui scena iniziale una strega afferma: «il male è potente», ossia «grande è la potenza del male»).
🛒 ricerche / acquisti
cerca libri su Amazon sul tema: Dostoevskij Karamazov lotta tra bene e male potenza del bene vittoria del bene arte musica letteratura cultura libri on-line I Fratelli Karamazov .